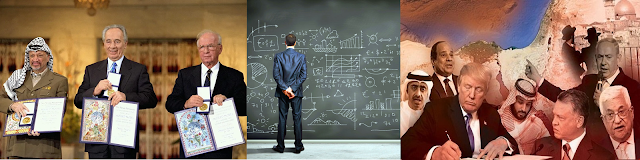Questione palestinese: la terza soluzione
Sembra
passato un secolo da quando nel 1993 a Oslo il primo ministro israeliano
Yitzhak Rabin e il presidente dell’Organizzazione per la Liberazione della
Palestina Yasser Arafat firmarono gli accordi che allora furono definiti
“storici”, in quanto sembravano rappresentare l’avvio della soluzione della
questione israelo-palestinese e prefigurare una futura creazione di due Stati
che pacificamente vivessero nello stesso territorio. Gli accordi infatti
prevedevano il graduale ritiro dell’esercito israeliano dai territori occupati,
l’istituzione dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) cui sarebbe stata
affidata la gestione amministrativa della Cisgiordania e di Gaza una volta
completato il ritiro dell’IDF (le Forze di Difesa Isaraeliane, cioè
l’esercito); soprattutto gli accordi sancivano un reciproco riconoscimento:
Israele riconosceva l’ANP come rappresentante del popolo palestinese e l’ANP il
diritto di esistere di Israele.
Negli
anni successivi Israele non ritirò neppure un soldato dai territori occupati dal
1967 e, anzi, favorì nuovi insediamenti illegali di coloni in Cisgiordania.
Questi fattori portarono inevitabilmente al fallimento dei colloqui,
organizzati dal presidente Clinton, che si tennero a Camp David nel 2000. In
quella sede il nuovo primo ministro israeliano Ehud Barak, su pressione dello
stesso Clinton, offrì all’ANP la cessione di gran parte dei territori occupati
e la possibilità di stabilire la capitale del nuovo Stato a Gerusalemme Est,
proposta che Arafat rifiutò. I media occidentali descrissero come generosa
l’offerta israeliana e incomprensibile il rifiuto palestinese, ma Israele
offriva una concessione e non l’accettazione del diritto di autodeterminazione
del popolo palestinese; l’ANP avrebbe potuto aprire i propri uffici a Gerusalemme
Est, ma questa – annessa de facto da Israele nel 1980 – sarebbe rimasta sotto
il controllo israeliano; il novanta per cento dei territori occupati da
affidare all’ANP non comprendeva una fascia di sicurezza che Israele intendeva
annettere al confine con la Cisgiordania e soprattutto non comprendeva le aree
dove si erano sviluppati gli insediamenti illegali di coloni, il che non
consentiva una continuità territoriale alla nuova entità palestinese, cui si
cedeva l’amministrazione civile e non quella militare del territorio (in
sostanza lo Stato palestinese sarebbe diventato una sorta di colonia
israeliana).
La
fine della speranza
Da allora la situazione è precipitata:
● a settembre, appena due mesi dopo Camp David, ci fu il
provocatorio ingresso alla spianata delle Moschee – luogo sacro per i musulmani
- a Gerusalemme del futuro premier israeliano Ariel Sharon con la scorta di
centinaia di poliziotti israeliani armati e in tenuta antisommossa. La
provocazione di quel 28 settembre fu l’avvio di una sollevazione palestinese -
la seconda intifada, nota come Intifada di Al-Aqsa - che causò in un solo mese
123 morti e 5.862 feriti fra i palestinesi, 7 soldati uccisi e 30 feriti fra
gli israeliani e la ripresa del conflitto armato tra i contendenti;
● nel 2004 l’esercito israeliano si ritirò da Gaza, primo e
finora unico episodio di ritiro dell’IDF da un territorio occupato, ma subito
la circondò impedendo ogni collegamento via terra o via mare che non fosse
autorizzato dall’esercito, rendendo da allora la Striscia di Gaza una grande
prigione a cielo aperto;
● le drammatiche condizioni di vita imposte a Gaza, privata
dell’energia elettrica e dei rifornimenti idrici, nonché di medicine, mezzi di
prima necessità e materiali da costruzione, portò - dopo poco più di un anno -
alla inattesa vittoria di Hamas, movimento che non riconosce a Israele il
diritto di esistere, nelle elezioni amministrative a Gaza. Il conflitto
israelo-palestinese si trasformò quindi in una guerra non dichiarata fra
Israele e Hamas, con due momenti culmine: l’invasione di Gaza da parte dell’IDF
nel 2014 e gli undici giorni di bombardamenti israeliani in risposta al lancio
di razzi da parte di Hamas nel maggio scorso;
● nel frattempo, nel distretto di Gerusalemme Est e nella
zona della Cisgiordania controllata esclusivamente dall’esercito israeliano
continuarono a essere costruiti insediamenti
illegali: oggi oltre mezzo milione di coloni (di cui duecentomila nella sola
Gerusalemme Est) vivono nei 138 insediamenti autorizzati – contro il diritto
internazionale - dal governo israeliano e negli oltre cento “avamposti” non
riconosciuti dalle autorità e quindi formalmente illegali anche per la legge
israeliana (ma cui l’esercito ugualmente costruisce vie di accesso e garantisce
collegamenti alle reti idriche ed elettriche, oltre alla protezione armata
dalle legittime proteste dei palestinesi dei villaggi vicini). Se si
considerano anche le infrastrutture stradali e i campi coltivati dai coloni,
gli insediamenti coprono poco meno della metà dell’intera Cisgiordania,
rendendo le città palestinesi – non più collegate fra loro – dipendenti per
tutto (dal rifornimento di acqua e combustibili, a quello di generi alimentari,
ai permessi di spostamento nella regione) dalle autorità israeliane;
● il colpo di grazia lo ha inferto l’amministrazione Trump
prima con il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele e il
conseguente spostamento della sua ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme, poi con
il Peace to Prosperity Plan, noto anche come l’“accordo del secolo”, piano di
pace che presenta una versione puramente simbolica della soluzione dei due
Stati: concede l’autonomia a Gaza (smilitarizzata con l’estromissione di Hamas
e affidata nominalmente al controllo egiziano), mentre prevede la sostanziale
annessione a Israele della quasi totalità della Cisgiordania, lasciando all’ANP
sei enclavi non collegate fra loro e contenenti le principali città abitate dai
palestinesi.
L’abbandono
della soluzione dei due Stati
L’accordo del secolo, salutato entusiasticamente dal governo Netanyahu e più tiepidamente (con qualche distinguo) dal nuovo governo Bennett-Gantz, oltre che da Arabia Saudita, Qatar e dai firmatari degli Accordi di Abramo, cioè Emirati Arabi Uniti e Bahrein, ha suscitato non poche perplessità e critiche.
Scontato
il rifiuto palestinese, vittima sacrificale dell’accordo di pace e neppure
consultato nella sua predisposizione, e registrato il dissenso della maggior
parte dei Paesi e delle organizzazioni internazionali, in Israele oppongono i
piccoli partiti progressisti alla Knesset (Meretz, Labor e la Joint List degli
arabo-israeliani che pure contribuiscono alla coalizione di governo) e –
paradossalmente, ma per opposti motivi - alcuni partiti sionisti di estrema
destra, particolarmente presenti nella comunità dei coloni israeliani, secondo
i quali il piano prevede una percentuale di territori da annettere inferiore
rispetto a quanto sperato.
Abbandonata,
in quanto non più percorribile, la soluzione dei due Stati nell’opinione
pubblica israeliana si sta diffondendo l’opzione di un unico Stato, ma con
connotazioni assai diverse fra i due schieramenti che la propongono: i partiti
progressisti e le organizzazioni non governative sia israeliane che
internazionali sognano, con una forte dose di utopia, uno Stato dove possano
convivere ebrei e palestinesi con gli stessi diritti e doveri; la destra invece
ripropone il vecchio obiettivo di una Grande Israele “dal fiume [Giordano] al
mare [Mediterraneo]”, cioè comprendente la terra promessa agli ebrei: la Giudea
e Samaria, come i sionisti chiamano la Cisgiordania.
In
tutto questo si inserisce l’atteggiamento del nuovo governo con il primo
ministro Naftali Bennett che - durante l’incontro con la
cancelliera tedesca Angela Merkel la quale sosteneva che “anche se in questa
fase sembra quasi senza speranza, l’idea di una soluzione a due Stati non
dovrebbe essere tolta dal tavolo” - ha risposto che “in base alla nostra
esperienza, istituire uno Stato palestinese significa molto probabilmente
istituire uno Stato del terrore, a circa sette minuti da casa mia e da quasi
ogni punto di Israele”.
Con questa affermazione Bennett sembra attribuire l’etichetta di “terrorista” non più solo ad Hamas o a Hezbollah, ma all’intero popolo palestinese. È in questa chiave che va probabilmente letta la decisione del ministro della Difesa Binyamin Gantz di mettere di fatto fuorilegge – con l’accusa di formare “una rete di organizzazioni attive sotto copertura” - sei gruppi per i diritti dei palestinesi (Addameer, Al-Haq, Bisan Center, Defense for Children International Palestine, l'Unione dei comitati delle donne palestinesi e l'Unione dei comitati dei lavoratori agricoli) che abitualmente collaborano con le Nazioni Unite, per presunti legami con il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP), un gruppo riconosciuto come terrorista da diversi governi occidentali.
Verso
una nuova Nakba?
“Sei
qui per errore, perché Ben-Gurion non ha finito il lavoro e non ti ha buttato
fuori nel 1948”, ha urlato il 13 ottobre scorso il deputato Bezalel
Smotrich
rivolto ai deputati arabi della Knesset durante un dibattito sulla già
ricordata proposta di modifica al legge sull’immigrazione, proposta dal suo
collega del sionismo religioso, Simcha Rothman. "Questa è la verità,
questa è la verità", ha ribadito Smotrich.
Il
riferimento è ovviamente all’esodo forzato dei palestinesi dal territorio che
le Nazioni Unite avevano destinato al nascente Stato di Israele nel 1948. Pochi
mesi prima della sua istituzione vi abitavano 806 mila ebrei e circa un milione
di palestinesi; nel 1949, al termine della guerra arabo-israeliana, il numero
dei palestinesi si era ridotto a poco più di centocinquanta mila. Oltre
settecento mila palestinesi abbandonarono le loro case negli anni tra il 1947 e
il 1949: una minima parte emigrò volontariamente nella speranza di far ritorno
alle proprie case al termine del conflitto, ma la stragrande maggioranza fu
costretta all’esodo dalle forze paramilitari israeliane, come Haganah, Palmach
e Irgun, che distrussero decine di villaggi palestinesi, uccidendo tutti gli
abitanti che si rifiutarono di abbandonarli: nel solo villaggio di Deir Yassin
che allora contava circa seicento abitanti un centinaio di miliziani di Irgun e
della cosiddetta Banda Stern furono fucilati o bruciati vivi oltre cento civili,
prevalentemente donne, bambini e anziani, dopo che per vincere la resistenza
dei pochi palestinesi armati gli ebrei avanzarono gettando bombe a mano in ogni
casa uccidendo sia i combattenti che gli altri abitanti.
I
palestinesi ricordano questa tragedia che molti storici - anche israeliani -
non esitano a definire una pulizia etnica con il termine Nakba (catastrofe in
arabo) e la commemorano ogni 15 maggio con manifestazioni che ovviamente
Israele ha vietato sul proprio territorio.
Oggi
i partiti israeliani di estrema destra come Tkuma, il partito sionista
religioso di cui è leader Smotrich, auspicano una nuova Nakba, con la
definitiva espulsione di tutti i palestinesi da Israele e dai territori
occupati, realizzando un esproprio totale della Palestina e la creazione di uno Stato etnico, Alcuni sostenitori di questa
aberrante soluzione la motivano con l’affermazione – basata su una lettura
parziale delle sacre scritture – che Eretz Yisrael fosse in origine abitata da
sole tribù ebree e che i palestinesi sopraggiunsero secoli dopo con
l’occupazione araba; una lettura parziale della Torah dove espressamente si
dice che Yahweh aveva promesso ai discendenti di Giacobbe la terra “presa
all’Amorreo”, con un chiaro riferimento alla popolazione semitica degli Amorrei
che vivevano in quel territorio già nel terzo millennio avanti Cristo.
Questa
seconda Nakba, se vedrà la luce, probabilmente non avrà i contorni cruenti
della prima, ma sarà diretta conseguenza dell’antipalestinesismo, termine coniato
dal giornalista ebreo americano Peter Beinart, alla base della politica del
governo di Israele e della sua connivenza verso le frange estremiste dei
movimenti sionisti di estrema destra.
<<<
--->>>
Potrebbero anche interessarti:
Una
tempesta in un… barattolo di gelato
“L’accordo
del secolo”: come i media globali hanno messo a tacere i palestinesi
Il
tradimento arabo della Palestina